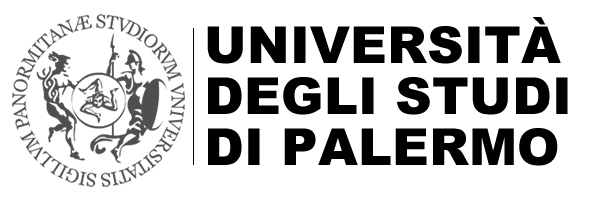Sconti per Gruppi!
Registrazione utente
Accesso utenti
Accedi/Registrati con le tue credenziali social
Non sei ancora iscritto o non hai effettuato l'accesso.
Per seguire tutte le attività iscriviti senza impegno.

Versione 1.1.23 (Build ufficiale) (a 64 bit)
Copyright 2025 Cammino Diritto Srl Tutti i diritti riservati.
WebMaster Raffaele Giaquinto
Richiesto abilitazione
Corsi Online
Stai per richiedere l'autorizzazione a FCD per poter creare un corso online.
Questa procedura consente di avere un primo contatto con lo staff di FCD.
Prima di tale richiesta ti invitiamo a inserire il tuo curriculum accademico all'interno dell'anagrafica. In seguito potrebbero essere richiesta documentazione attestante i titoli vantati e la relativa idoneità a produrre corsi idonei per FCD.
Prepararsi a questo concorso significa ambire a un ruolo di prestigio e responsabilità nel cuore dell’amministrazione finanziaria dello Stato. Con 2.700 posti a tempo indeterminato, il concorso rappresenta una delle più importanti occasioni di inserimento nella pubblica amministrazione del 2025. Il nostro corso è stato ideato per accompagnarti passo dopo passo verso il superamento della prova scritta, con un metodo completo, flessibile e altamente formativo.
Con Cammino Diritto, non acquisti solo un pacchetto di lezioni: entri in un percorso di crescita personale e professionale, costantemente aggiornato, costruito intorno alle esigenze di chi vuole davvero cambiare il proprio futuro. Le lezioni sono curate da docenti esperti, con un taglio operativo e un linguaggio chiaro, capaci di trasformare anche gli argomenti più tecnici in strumenti utili per affrontare con consapevolezza la prova.
Il corso prevede:
videolezioni approfondite per ciascuna materia prevista dal bando;
dispense chiare ed essenziali;
simulazioni della prova a risposta multipla;
tutoraggio dedicato;
supporto tecnico costante.
Ti aiuteremo a padroneggiare ogni argomento, dalla normativa tributaria al diritto dell’Unione Europea, dalla contabilità aziendale alla disciplina penale dei reati tributari, con un focus mirato anche su inglese e competenze informatiche.
Questo concorso non è solo un’opportunità lavorativa: è la porta di accesso a una carriera stabile, dinamica e carica di significato, al servizio della legalità e della giustizia fiscale. Superarlo richiede impegno, ma non sarai solo. Noi saremo con te, lezione dopo lezione.
In questa lezione è data una presentazione degli argomenti basilari del diritto tributario, dal concetto di tributo, all’aliquota, alla base imponibile.
parte prima
La lezione è incentrata sulla disciplina del rapporti di debito/credito intercorrente tra contribuente e amministrazione finanziaria, con attenzione ai profili sovranazionali.
parte seconda
parte prima
Nel corso della lezione sono oggetto di approfondimento i vari metodi di riscossione, volontaria e coattiva, ed è oggetto di particolare attenzione il procedimento tributario conseguente all’avviso di accertamento
parte seconda
parte terza
parte prima
La lezione presenta le principali sanzioni, penali ed amministrative, connesse a condotte elusive ed evasive fiscalmente rilevanti.
parte seconda
parte prima
Oggetto della lezione è il codice del processo tributario, dall’analisi della giurisdizione delle Commissioni tributarie fino al ricorso per cassazione
parte seconda
Il modulo si propone di trattare la definzione dell'imprenditore ex art. 2082 c.c. Il modulo si apre con tale definzione e prosegue con la distinzione della nozione economica e giuridica della figura dellimprenditore.
Verranno trattati i requsiti giuridici richiesti dalla norma affinchè l'imprenditore possa essere qualificato come tale.
Un breve focus sarà posto anche sullo scopo di lucro e si vedrà anche la distinzione tra lucro oggettivo e lucro soggettivo.
Nel modulo, sarà trattata anche l'attività illecita e come tale attività incide sulla qualifica dell'imprenditore.
Infine, vedremo come l'esercizio delle professioni intelelttuali possa configurarsi come attività di impresa.
Nel presente modulo tratteremo le diverse tipologie di imprenditori, qualificati in base a specifici criteri di distinzione dettati dalle singole norme.
Nello specifico vedremo l'imprenditore commerciale, l'imprenditore civile e l'imprenditore agricolo.
In merito a quest'ultimo, analizzeremo l'art. 2135 c.c., le attività essenziali e le attività per connessione.
In questo modulo andremo a trattare la figura del piccolo imprenditore, qualificato come tale in base al criterio dimensionale dell'impresa.
Nello specifico, vedremo la definizione di piccolo imprenditore data dal codice civile e dalla legge fallimentare.
Durante la lezione, vedremo anche le caratteristiche dell'impresa artigiana così come definita dalla legge nr. 860/1956 e abrogata dalla legge nr. 443 del 08/08/1985 (legge quadro sull'artigianato).
Infine, concluderemo il modulo con la presentazione dell'impresa familiare e della tutela offerta dal legislatore.
Nel presente modulo sarà trattata la distinzione tra impresa individuale e impresa collettiva,
Vedremo come per l'impresa individuale l'attività di impresa è svolta da una sola persona fisica, mentre per l'impresa collettiva sarà svolta da più persone fisiche o giuridiche.
Per entrambe le tipologie di imprese vedremo i vantaggi e gli svantaggi che li caratterizzano.
Analizzeremo anche l'impresa pubblica e il fenomeno della privatizzazione, nonchè l'attività svolta dalle associazioni e dalle fondazioni.
Concluderemo il modulo con la figura dell'impresa sociale.
Nel presente modulo vedremo come si acquista la qualità di imprenditore e i criteri di imputazione degli atti negoziali, quali la spendita del nome.
Vedremo il fenomeno dell'imprenditore occulto, dell'inzio dell'impresa e della sua fine.
Nel presente modulo tratteremo lo statuto dell'imprendiotre commerciale e la differenza rispetto allo statuto speciale dell'imprenditore commerciale.
Vedremo che cos'è la pubblicità legale e di come è variata la disciplina nel corso degli anni, fino ad arrivare alla nascita del registro delle imprese.
In merito a quest'ultimo, vedremo come è organizzato, le sezioni che lo compongono, il procedimento di iscrizione e gli effetti dell'iscrizione.
Andremo ad analizzare anche le scritture contabili, così come il perché della loro importanza. Inoltre, vedremo perché in alcune società di capitali e società cooperative i dati contabili devono essere resi pubblici.
Affronteremo, infine, l'istituto della rappresentanza commerciale e le figure interne ed esterne che possono agire in rappresentanza dell'imprenditore.
Nel presente modulo tratteremo l'azienda, così come viene definita dal codice civile.
Vedremo la differenza tra avviamento oggettivo e soggettivo, gli elementi costitutivi e il contrasto tra concezione atomistica e unitaria dell'impresa.
Capiremo come l'azienda possa essere oggetto di atti di disposizoone come vendita, conferimento in società, donazione, usufrutto e affitto.
Nella seconda parte del modulo, oggetto di trattazione saranno i cosnorzi fra imprenditori.
Affronteremo i tratti caratteristici stabiliti dall'art 2063 c.c e la distinzione fra consorzi con attività interna e consorzi con attività esterna.
Ci soffermeremo sulle società consortili e sullo scopo da queste perseguite.
Analizzeremo il GEIE e di come questo sia disciplinato a livello comunitario e nazionale, nonché la sua struttura e i requisiti necessari per il suo funzionamento.
Alla fine tratteremo le associazioni temporanee di imprese (joint ventures) e come si comportano quando devono partecipare agli appalti pubblici.
Nel presente modulo tratteremo i segni distintivi che l'imprenditore può utilizzare come ad es. la ditta, il marchio e l'insegna.
Per ognuno di questi segni vedremo quali sono i requisiti per la loro validità.
Nella seconda parte vedremo le opere dell'ingegno, quali le creazioni intellettuali, il diritto d'autore, le invenzioni industriali, il brevetto e i modelli industriali.
Come i segni distintivi, anche le opere dell'ingegno presentano delle caratteristiche di validità.
Nel presente modulo tratteremo la disciplina della concorrenza e di come determinati fattori portano il mercato in una situazione di concorrenza, oligopolio e monopolio.
Vedremo i fenomeni rilevanti per la disciplina antomonopolistica come le instese restrittive della concorrenza, gli abusi della posizione dominante e le concentrazioni.
Analizzeremo i divieti legali e le limitazioni della concorrenza.
Affronteremo la concorrenza sleale e le fattispicie tipiche come gli atti di confusione, denigrazione e altre situazioni. Vedremo quali sono le sanzioni previste per questi comportamenti.
Concluderemo il modulo con le pratiche commerciali scorrette e il fenomeno della pubblicità ingannevole e comparativa.
Nel presente modulo andremo a trattare le società, partendo dalla distinzione in due macro categorie: società di persone e società di capitali per poi vedere gli 8 modelli di organizzazione che derivano dalle 2 catgorie.
Vedremo come per la costituzione di una società sia necessario un contratto do società.
Andremo a vedere i vari tipi di conferimenti e come questi contribuiscono a dotare la società del capitale di rischio iniziale, nonchè l'oggetto sociale.
Affronteremo la società tra professionisti e le sue caratteristiche.
Oggetto di studio saranno anche lo scopo della società che, in base al risultato da raggiungere, si distingue in scopo lucrativo, mutualistico e consortile.
Poi cercheremo di capire la differenza tra il binomio società - associazioni e società - comunione, fino ad arrivare alle differenze inerenti ai diversi tipi di società, che dipendono principalmente dalla personalità giuridica e dall'autonomia patrimoniale.
Nel presente modulo andremo a trattare le società di persone che si distinguono in società semplice, società in nome collettivo e la società in accomandita semplice.
Vedremo la costituzione delle società di persone e i fenomeni che portano alla nascita di una società di fatto, di una società occulta o di una società apparente.
Analizzeremo come avvengono i conferimenti e le partecipazioni agli utili e alle perdite da parte dei soci.
In merito a questi ultimi vedremo come si comportano nei confronti delle obbligazioni sociali e come avviene l'amministrazione della società.
Affronteremo le modificazioni dell'atto costitutivo, lo scioglimento della società, la sua liquidazione e l'estinzione.
Nella seconda parte del modulo tratteremo la società in accomandita semplice, la sua costituzione e amministrazione.
Vedremo le due categorie di soci che caratterizzano questo tipo di società: soci accomandanti e soci accomandatari.
Vedremo il trasferimento e lo scioglimento della società, nonché il configurarsi di una sas irregolare quando mancano determinati presupposti.
Nel presente modulo andremo ad affrontare le società per azioni e le sue caratteristiche, passando per l'evoluzione della disciplina.
Vedremo le varie riforme, ad es. quella del 1974, 1988 e 2003.
Vedremo il procedimento di costituzione passando per la redazione dell'atto costitutivo, quale atto pubblico indispensabile e l'iscrizione nel registro delle imprese.
Analizzeremo le situazioni che presentano dei vizi e anomalie e che possono portare alla nullità del contratto.
Nel presente modulo tratteremo la società per azioni unipersonale e la novità introdotta nel 2003 per quanto riguarda i patrimoni destinati, considerati un modo alternativo di finanziamento.
Vedremo la specifica discplina in tema di conferimenti e capitale sociale.
Infine, ci soffermeremo sulla valutazione, quale procedimento specifico per i conferimenti diversi dal denaro.
Nel presente modulo andremo a trattare le azioni e i caratteri tipizzanti, nonché le partecipazioni azionarie e i diritti degli azionisti.
Vedremo le categorie speciali di azioni e la circolazione delle azioni, ma allo stesso tempo i vincoli e i limiti alla circolazione delle azioni.
Per ultimo affronteremo le partecipazioni reciproche e le singole fattispecie.
Nel presente modulo tratteremo la disciplina delle partecipazioni rilevanti e tutti i comportamenti che deve osservare chiunque intenda acquistare una partecipazione di controllo in una società con azioni quotate.
Vedremo che cosa sono le offerte pubbliche di acquisto (OPA) e tutte le sue particolarità.
Infine tratteremo le società controllate e la disciplina dei gruppi.
Nel presente modulo andremo a trattare uno degli organi che caratterizzano la S.p.A: L'assemblea dei soci.
Vedremo l'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria, il procedimento e la sua costituzione.
Inoltre, affronteremo la validità delle deliberazioni assembleari e come sono distribuiti i poteri all'interno dell'assemblea e che vengono espressi attraverso il diritto di voto.
Oggetto di approfondimento sarà anche la rappresentanza in assemblea esercitata personalmente dai soci oppure a mezzo di rappresentanze.
Vedremo che cosa sono i sindacati di voto e le invalidità delle deliberazioni.
Nel presente modulo tratteremo la figura degli amministratori di una S.p.A, come avviene la loro nomina e quali sono le cause che portano alla cessazione dell'incarico, nonché i compensi spettanti e divieti connessi all'esercizio della loro funzione.
Poi, vedremo il consiglio di amministrazione, come si compone e a quale altro organo può delegare le proprie attribuzioni.
Affronteremo le responsbailità delle varie fingure, come ad es. quella degli amministratori verso la società, verso i creditori sociali e i singoli soci.
In questo modulo tratteremo l'organo di controllo interno delle società per azioni: il collegio sindacale.
Vedremo come tra le sue funzioni rientra il controllo sull'amministrazione.
Inoltre, ci soffermeremo sul suo funzionamento e la responsbailità dei sindaci.
Nella seconda parte, vedremo il controllo contabile e di come questo si differenzi a seconda che si tratti di società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.
Vedremo, inoltre, i sistemi alternativi di controllo in base al sistema che le società hanno deciso di adottare, ovvero monistico, dualistico oppure tradizionale.
Infine, vedremo la Consob e i suoi tratti caratterizzanti.
Nel presente modulo tratteremo il bilancio, quale documento contabile da redigere alla fine di ciascun esercizio.
Vedremo come si struttura e che cosa sono i criteri di valutazione, nonché il procedimento utile alla sua formazione fino ad arrivare agli utili, dividendi e riserve.
Infine, affronteremo brevemente il bilancio consolidato di gruppi.
Nel presente modulo tratteremo le modificazioni dello statuto, del capitale sociale dovuto ad aumenti o riduzioni.
Vedremo che cos'è il diritto di opzione e quando può essere esercitato.
Nel presente modulo ci soffermeremo sulle società a responsabilità limitata.
Nello specifico vedremo i conferimenti e le forme di finanziamento, così come il capitale che è diviso secondo un criterio personale (quote sociali).
Oggetto di trattazione saranno anche il trasferimento delle quote e gli organi sociali che compongono la srl e come viene svolta l'amministrazione di questo tipo di società.
Nella seconda parte vedremo la disciplina della S.a.p.a e le sue cartteristiche.
Nel presente modulo affronteremo il tema delle obbligazioni nella prima parte e i limiti alle loro emissioni, passando per il procedimento.
Ci soffermeremo brevemente sulla disciplina dettata per le obbligazioni convertibili in azioni, nonché sull'organizzazione del gruppo articolata in due organi: l’assemblea ed il rappresentante comune.
Nella seconda parte tratteremo lo scioglimento della società per azioni e le cause che determinano questo stato.
Vedremo poi il procedimento di liquidazione e la nomina dei liquidatori.
Nel presente modulo andremo a trattare le società cooperative, come vengono costituite e cosa prevede la riforma del 2003.
Ci soffermeremo sullo scopo mututalistico perseguito dalle società cooperative e sulle cooperative a mutualità prevalente, nonché sul carattere strutturale delle stesse.
Vedremo la disciplina dei conferimenti e la partecipazione sociale, gli organi sociali e il sistema di controllo, affidato a diversi soggetti.
Oggetto di studio sarà anche la variazione della compagine societaria e del capitale sociale.
Infine, concluderemo la lezione con le organizzazioni di gruppo e lo scioglimento della società.
Nel presente modulo affronteremo l'istituto della trasformazione e la sua distinzione in trasformazione omogenea ed eterogenea e il relativo procedimento.
Vedremo la responsabilità dei soci in merito alla trasformazione.
Poi affronteremo l'istituto delle fusioni e il progetto di fusione, quale fase "preparatoria" dell'intero iter. Poi vedremo il secondo step: la delibera di fusione e l'atto di fusione, quale passaggio finale per il completamento del procedimento.
Infine, tratteremo l'istituto della scissione e il relativo procedimento.
Nel modulo sarà trattato il contratto del mandato e la distinzione in mandato con e senza rappresentanza.
Saranno affrontate le obbligazioni in capo al mandatario e al mandante e le cause di estinzione del contratto di mandato.
Vedremo due sottotipi di mandato senza rappresentanza: commissione e spedizione.
Oggetto di studio sarà anche il conto corrente ordinario per quanto riguarda la sua funzione, e le cause che portano alla chiusura del conto.
Nel presente modulo andremo a trattare anche i contratti bancari.
Nello specifico vedremo il contratto di deposito bancario, l'apertura del credito e le varie garanzie, nonché il recesso da questo tipo di contratto.
Affronteremo inoltre l'anticipazione bancaria e gli elementi caratterizzanti; il contratto di sconto e la sua funzione; le operazioni in conto corrente e le operazioni bancarie accessorie come i vari depositi.
Concluderemo il modulo con l'attività di intermediazione esercitata dalla banca.
Slides sul modulo di intermediazione finanziaria
Nel presente modulo andremo a trattare i titoli di credito e le varie distinzioni.
Andremo a trattare i principi ,contenuti nella disciplina generale dei titoli di credito.
Vedremo che cosa sono i titoli astratti e i titoli causali, nonché la circolazione dei titoli di credito.
Analizzeremo la girata con tutte le sue caratteristiche e funzioni e i titoli nominativi.
Affronteremo i diritti cartolari e la legittimazione all'esercizio di tale diritto, nonché le eccezioni al loro utilizzo.
Infine, concluderemo il modulo con l'istituto dell'ammortamento.
Nel modulo sulla cambiale, andremo a vedere la cambiale e la sua funzione .
Sarà trattata anche la sua struttura insieme ai requisiti essenziali e naturali, nonché le obbligazioni che tale titolo incorpora e la sua accettazione.
Oggetto di trattazione sarà anche la cambiale in bianco.
Ci soffermeremo brevemente sulla figura dell'avallo.
Proseguiremo la lezione con la circolazione della cambiale e sul pagamento. In merito a quest'ultimo vedremo la differenza tra pagamento parziale e pagamento per intervento.
In più, vedremo le azioni messe in atto da parte del portatore per vedersi pagata la somma a lui spettante in caso di rifiuto del pagamento, nonchè le azioni eztra cambiarie.
Infine, vedremo il processo cambiario, l'ammortamento e le cambiali finanziarie.
Nel presente modulo tratteremo la nozione di assegno bancario, la sua funzione e la distinzione rispetto alla cambiale tratta.
Indicheremo i requisti di regolarità e validità, nonchè la posizione della Banca trattaria.
Analizzeremo il pagamento dell'assegno bancario e le azioni previste lato portatore, in caso di mancato pagamento da parte della banca trattaria.
Vedremo il significato e le caratteristiche dell'assegno sbarrato, da accreditare non trasferibile e dell'assegno turistico.
Brevemente tratteremo la disciplina dell'ammortamento.
Concluderemo il modulo con un altro titolo di credito: l'assegno circolare.
La presente lezione ha lo scopo di definire, con riferimento all'oggetto dell'azienda, le differenze tra le aziende di produzione e quelle di consumo.
In particolare, verranno esaminate le diverse forme di aziende di erogazone e le diverse forme di impresa e di produzione.
La presente lezione intende analizzare le differenze tra soggetto giuridico e soggetto economico, sia con riferimento alle società di persone che di capitali, sia analizzando i profili relativi ai gruppi di imprese, public company e aziende pubbliche
In questa lezione si affronta la composizione dell'ambiente all'interno del quale opera l'impresa, analizzandolo sia da un punto di vista generale che competitivo. Si evidenzia anche come l'azienda, per adattarsi alle mutevoli condizioni ambientali, deve innovarsi e tener conto dei diversi rischi che ne minacciano la capacità di produrre e quindi la stessa sopravvivenza.
Gli elementi costitutivi dell'azienda sono i fattori che, combinati tra loro, permettono ad un'azienda di svolgere la propria attività.
In dettaglio, gli elementi costitutivi dell'azienda sono:
Gli elementi costitutivi dell'azienda sono strettamente interconnessi tra loro. Ad esempio, la struttura organizzativa influenza le persone che lavorano all'interno dell'azienda, i beni economici che vengono utilizzati e le operazioni che vengono svolte. Allo stesso modo, le persone che lavorano all'interno dell'azienda contribuiscono a creare la struttura organizzativa, a utilizzare i beni economici e a svolgere le operazioni.
La comprensione degli elementi costitutivi dell'azienda è fondamentale per la gestione aziendale. Gli imprenditori e i manager devono essere in grado di identificare e comprendere questi elementi al fine di prendere decisioni efficaci e di raggiungere gli obiettivi aziendali.
Lo scopo di questa lezione è di esaminare i finanziamenti in base alla loro provenienza, distinguendo tra capitale di rischio e capitale di credito. Si affronta anche il concetto di utili, riserve disponibili e riserve indisponibili, delineando le varie categorie di riserve e le loro origini.
Si affrontano i finanziamenti in base alla loro durata, distinguendo tra finanziamenti a medio-lungo termine e a breve termine o correnti e vengono esaminati vari tipi di finanziamenti bancari, anticipazioni su pegno di beni, anticipazioni di crediti, mutui e prestiti obbligazionari. Si sottolinea l'importanza della stabilità dei finanziamenti e delle relazioni aziendali.
Infine, si esamina il concetto di capitale intellettuale, suddividendolo nelle sue tre componenti principali: capitale umano, capitale relazionale e capitale strutturale, sottolineando come la cultura aziendale sia fondamentale per la gestione del capitale intellettuale.
Un sistema aziendale è un insieme di elementi, umani e non umani, che interagiscono tra loro per raggiungere un obiettivo comune. Gli elementi umani includono dipendenti, manager, fornitori e clienti. Gli elementi non umani includono beni economici, come il capitale, il lavoro e le risorse naturali, nonché processi, tecnologie e informazioni.
Le operazioni di gestione sono strettamente interconnesse tra loro. Ad esempio, la fase di trasformazione dipende dalla fase di provvista, in quanto i fattori produttivi necessari alla trasformazione devono essere acquisiti prima. Allo stesso modo, la fase di scambio dipende dalla fase di trasformazione, in quanto i prodotti o servizi che sono stati creati devono essere disponibili per essere scambiati.
I valori relativi alle operazioni di gestione sono fondamentali per la gestione aziendale. Gli imprenditori e i manager devono essere in grado di identificare e comprendere questi valori al fine di prendere decisioni efficaci e di raggiungere gli obiettivi aziendali.
Per esempio, un'azienda che desidera aumentare i propri profitti potrebbe cercare di ridurre i costi o aumentare i ricavi. Un'azienda che desidera migliorare la propria posizione finanziaria potrebbe cercare di aumentare il capitale proprio o ridurre il capitale di terzi.
Il risultato economico è la misura della redditività di un'azienda. È la differenza tra i ricavi e i costi di un'azienda in un determinato periodo di tempo. Se i ricavi sono maggiori dei costi, l'azienda genera un profitto. Se i costi sono maggiori dei ricavi, l'azienda registra una perdita.
Il reddito è un concetto più ampio del risultato economico. Il reddito può includere il risultato economico, ma può anche includere altre voci, come le plusvalenze e le minusvalenze, i contributi in conto capitale e le imposte.
In questa lezione si affronta in modo dettagliato la complessa questione della contabilizzazione delle scorte, delle valutazioni dei costi e dei ricavi, nonché dei principi di competenza economica e finanziaria nell'ambito della determinazione del reddito di esercizio.
Il reddito e il capitale sono due concetti fondamentali nell'economia aziendale. Il reddito è l'accrescimento che il capitale di un'impresa subisce in conseguenza della gestione. Il capitale, invece, è la ricchezza di un'impresa, rappresentata dai beni economici di cui dispone.
Le relazioni tra reddito e capitale sono molteplici. Innanzitutto, il reddito è una fonte di finanziamento del capitale. Il reddito generato dall'azienda può essere utilizzato per reinvestire nell'azienda, per remunerare i soci o per distribuire dividendi.
Esistono diversi modi per raggiungere l'equilibrio economico. Uno dei modi più comuni è aumentare i ricavi, ad esempio attraverso una maggiore vendita di prodotti o servizi o attraverso un aumento dei prezzi. Un altro modo è ridurre i costi, ad esempio attraverso una riduzione degli sprechi o attraverso un aumento dell'efficienza.
La lezione affronta principalmente il concetto di equilibrio economico nell'ambito dell'impresa e dei fattori che influenzano tale equilibrio secondo quesi punti chiave:
in questa lezione si affronta l'analisi dei costi e alla loro attribuzione ai prodotti in un'azienda.
La lezione intende fornire una panoramica dettagliata dei concetti relativi alla gestione dei costi aziendali e alla loro attribuzione ai prodotti, fornendo informazioni utili per la pianificazione e la gestione aziendale.
In questa lezione si affronta l'analisi dei costi e alla loro attribuzione ai prodotti in un'azienda.
Questa lezione affronta principalmente il concetto di equilibrio finanziario nell'ambito della gestione aziendale.
Questa lezione tratta principalmente del concetto di autofinanziamento nelle imprese e dei meccanismi attraverso i quali le imprese possono soddisfare il proprio fabbisogno finanziario senza dover ricorrere al mercato dei capitali.
Autofinanziamento: Si tratta del processo attraverso il quale le imprese cercano di coprire il proprio fabbisogno di capitale utilizzando i loro redditi interni, anziché cercare finanziamenti esterni.
Accantonamenti: L'autofinanziamento avviene principalmente tramite gli accantonamenti, che rappresentano il denaro trattenuto dall'azienda per scopi futuri.
Ricchezza lorda e netta: La ricchezza lorda deriva dai ricavi ottenuti dalle vendite, mentre la ricchezza netta è data dagli utili netti, ossia la differenza tra i ricavi e i costi.
Tipi di accantonamenti: Esistono due tipi di accantonamenti: da utili netti e da utili lordi.
Benefici dell'autofinanziamento: L'autofinanziamento offre vantaggi come l'assenza di interessi, flessibilità finanziaria e stabilità politica all'interno dell'impresa.
Vincoli all'autofinanziamento: L'autofinanziamento può essere limitato da vari fattori, tra cui la necessità di utili, una gestione redditizia e la rinuncia agli utili da parte dei soci.
Autofinanziamento occulto: A volte, le imprese nascondono l'autofinanziamento attraverso la sottostima di alcune valutazioni contabili, come il valore delle rimanenze di magazzino o degli ammortamenti, per non influenzare i rapporti sociali o mascherare situazioni di crisi.
Accantonamenti da utili lordi: Questi accantonamenti vengono costituiti al momento della determinazione del reddito di esercizio e possono essere divisi in due categorie: accantonamenti correttivi (per correggere eventi erosivi passati) e accantonamenti per riserve di provvisione (per affrontare eventi erosivi futuri).
Equilibrio economico, finanziario e autosufficienza: L'equilibrio economico, basato su ricavi e costi, è cruciale per la sopravvivenza a lungo termine di un'impresa. L'equilibrio finanziario, basato sulle entrate e le uscite, è altrettanto importante, ma deve essere supportato dall'equilibrio economico. L'autosufficienza dell'impresa è fondamentale per garantire la sua durata nel tempo.
Autosufficienza oggettiva e soggettiva: L'autosufficienza oggettiva si riferisce alla reale capacità di un'impresa di produrre reddito autonomamente e risparmiarlo. L'autosufficienza soggettiva è apparente ed è supportata da fonti esterne, come contributi patrimoniali o posticipi di pagamento.
Le rilevazioni contabili e extra-contabili sono due categorie di rilevazioni che le aziende effettuano per ottenere informazioni utili alla gestione.
Le rilevazioni contabili sono quelle che riguardano gli aspetti economici e finanziari dell'azienda. Sono registrate nei libri contabili, come il libro giornale, il libro mastro e il bilancio.
Le rilevazioni extra-contabili sono quelle che riguardano gli aspetti non economici e finanziari dell'azienda. Sono registrate in documenti diversi dai libri contabili, come i grafici, i tabelle e i report.
Le rilevazioni contabili sono fondamentali per il controllo della gestione. Consentono di monitorare l'andamento economico-finanziario dell'azienda e di prendere decisioni efficaci.
Le rilevazioni extra-contabili possono essere utili per migliorare la comprensione dei dati economici e finanziari. Possono essere utilizzate per identificare tendenze, problemi e opportunità.
In economia e contabilità aziendale, le rilevazioni contabili e extra-contabili sono due strumenti fondamentali per la gestione aziendale.
La lezione tratta i seguenti argomenti:
Controllo direzionale e controllo operativo: Si discute dei due livelli di controllo all'interno delle organizzazioni, il controllo direzionale (a livello strategico) e il controllo operativo (a livello delle attività quotidiane).
Assegnazione degli obiettivi: Si spiega come vengono assegnati gli obiettivi alle unità organizzative, con un'enfasi sulla personalizzazione tramite negoziazione.
Misure e confronto: Si affronta il processo di misurazione delle performance e il confronto con gli obiettivi per individuare gli scostamenti.
Correzioni e feedback: Si descrive come vengono apportate correzioni in risposta agli scostamenti e l'importanza del feedback.
Forme di controllo: Si introducono tre forme di controllo: antecedente (preventivo), concomitante (durante l'attività) e successivo (dopo l'attività).
Controllo strategico: Si spiega il controllo strategico, finalizzato a valutare l'efficacia a breve e lungo termine delle attività aziendali.
Meccanismi di rilevazione: Si menziona l'importanza degli strumenti di rilevazione come la contabilità generale, la contabilità analitica e il budget.
Piani temporali delle rilevazioni: Si presenta la distinzione tra rilevazioni antecedenti, concomitanti e susseguenti.
Rilevazioni contabili ed extra-contabili: Si spiega la differenza tra rilevazioni contabili, basate sul conto, e rilevazioni extra-contabili, che utilizzano altri strumenti.
La partita doppia è un metodo di scrittura contabile che consiste nella registrazione delle operazioni aziendali simultaneamente su due serie di conti: i conti di natura economica e i conti di natura finanziaria.
I conti di natura economica registrano gli aspetti economici dell'operazione, come i ricavi, i costi e le variazioni di capitale. I conti di natura finanziaria registrano gli aspetti finanziari dell'operazione, come i movimenti di denaro.
Il principio della partita doppia afferma che ogni operazione aziendale ha due aspetti, economico e finanziario, e che questi due aspetti devono essere registrati simultaneamente.
In questa lezione si affronteranno dei casi pratici di rilevazioni in partita doppia a partire dalla costituzione dell'impresa e proseguendo delle elementari operazioni di gestione
In economia e contabilità aziendale, l'assetto è il complesso dei beni di un'azienda, sia fisici che immateriali. L'inventario, invece, è una raccolta sistematica dei beni di un'azienda, in cui vengono indicati i beni, la quantità, il valore e la ubicazione.
L'assetto è una componente fondamentale del bilancio di un'azienda. Il bilancio è un documento contabile che fornisce una panoramica della situazione finanziaria e patrimoniale di un'azienda. L'assetto è riportato nello stato patrimoniale, che è una delle due sezioni principali del bilancio.
L'inventario è un'attività importante per le aziende. Consente di tenere traccia dei beni dell'azienda e di garantire che questi siano contabilizzati correttamente. L'inventario viene solitamente effettuato periodicamente, ad esempio una volta all'anno.
in questa lezione di tratta principalmente di:
Le rettifiche sottrattive in economia e contabilità aziendale sono le scritture contabili che servono a ridurre i costi o i ricavi di competenza di un esercizio. Queste rettifiche sono necessarie per garantire che il conto economico rappresenti correttamente l'andamento economico dell'azienda nell'esercizio di riferimento.
La presente lezione tratta dei seguenti argomenti:
In economia e contabilità aziendale, le rettifiche integrative sono le scritture contabili che vengono effettuate alla chiusura dell'esercizio per rettificare i valori dei costi e dei ricavi già rilevati durante l'esercizio. Queste rettifiche sono necessarie per rispettare il postulato della competenza economica, secondo il quale i costi e i ricavi devono essere rilevati nell'esercizio in cui sono sostenuti o realizzati, indipendentemente dal momento in cui vengono incassati o pagati.
Il conto economico e lo stato patrimoniale sono due documenti contabili fondamentali che rappresentano la situazione finanziaria di un'azienda. Il conto economico mostra i risultati economici dell'azienda per un periodo di tempo, mentre lo stato patrimoniale mostra la situazione patrimoniale dell'azienda in un determinato momento.
In economia e contabilità aziendale, la riapertura dei conti è l'operazione di riportare all'inizio dell'esercizio successivo i saldo dei conti contabili, al fine di poterli utilizzare per registrare i fatti di gestione del nuovo periodo contabile.
La riapertura dei conti si effettua al termine di ogni esercizio contabile, prima di iniziare il nuovo. È un'operazione necessaria per garantire la continuità delle registrazioni contabili e per poter confrontare i dati del nuovo esercizio con quelli dell'esercizio precedente.
La riclassificazione del conto economico e dello stato patrimoniale è un'operazione contabile che consiste nel riordinare le voci di questi documenti secondo criteri diversi da quelli utilizzati nel bilancio tradizionale. I criteri di riclassificazione più comuni sono:
La riclassificazione del conto economico e dello stato patrimoniale può essere utile per una migliore comprensione della situazione finanziaria e patrimoniale dell'azienda. Ad esempio, la riclassificazione per criterio finanziario può aiutare a valutare la liquidità dell'azienda, mentre la riclassificazione per criterio gestionale può aiutare a valutare l'efficienza della gestione.
In questa lezione si concentra l'attenzione su una serie di indicatori finanziari chiave utilizzati nell'analisi finanziaria, come il Margine di Tesoreria, l'Indice di Liquidità, il Margine di Struttura, l'Indice di Autocopertura del Capitale Fisso e altri. Si spiega il significato e l'importanza di ciascun indicatore nell'analisi della situazione finanziaria di un'azienda. Infine, si affronta l'analisi della redditività, includendo concetti come il ROI e il ROE, insieme alle loro formule e significati. Questo approccio fornisce una panoramica completa degli aspetti chiave dell'analisi finanziaria aziendale e dell'importanza dei principali indicatori nel processo decisionale finanziario.
L'obiettivo di questa lezione è quello di fornire una più dettagliata panoramica sui principi di redazione del bilancio aziendale, con un'enfasi particolare sull'art. 2423-bis del codice civile italiano. I principi includono la prudenza nella valutazione delle voci, la continuità aziendale, la prevalenza della sostanza, la competenza economica, la costanza nei criteri di valutazione, la rilevanza delle informazioni, e la comparabilità spazio-temporale dei valori nei bilanci. Inoltre, si parlerà dell'importanza dei principi contabili OIC e IAS nel contesto della redazione del bilancio aziendale.
I principi del diritto amministrativo: dall'organizzazione della P.A. all'azione amministrativa.
Le ordinanze sindacali (aggiornate alle recenti modifiche al T.U.E.L.) Le disposizioni contenute nel Testo unico degli enti locali – D. Lgs. n. 267 del 2000 – attribuiscono al Sindaco, tra l’altro, il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti.
Cosa si intende per pubblico impiego e come è disciplinato. La privatizzazione e gli aspetti che ne sono rimasti esclusi
Altre ipotesi patologiche dell'atto amministrativo. Altre tipologie di vizi, già conosciute al diritto civile, quali la nullità, l’inesistenza e la irregolarità.
Il ricorso gerarchico è una istanza interna stragiudiziale rivolta contro la pubblica amministrazione per gli atti amministrativi.
Un tribunale amministrativo regionale (TAR) è, nell'ordinamento della Repubblica italiana, un organo di giurisdizione amministrativa.Come si redige un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale? A cosa fare attenzione?
Nell'ordinamento giuridico italiano il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è un peculiare ricorso amministrativo, disciplinato dal Decreto del presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199.
Ha carattere alternativo rispetto ai ricorsi giurisdizionali, e può essere esperito nelle sole materie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, da chi intenda tutelare un proprio diritto (nelle sole materie di giurisdizione esclusiva) o interesse legittimo, contro atti della pubblica amministrazione.
I caratteri strutturali dell’illecito erariale.
Dall'ottemperanza al rito elettorale, vediamo le peculiarità di alcuni riti speciali del processo amministrativo.
" La crisi dell’impresa è un fenomeno che interessa non solo l’imprenditore e l’apparato produttivo del suo business, ma altresì una serie di interessi privati e pubblicistici di non poco momento.
La necessità da parte del diritto di regolare questo specifico fenomeno sorge da una serie di fattori, i quali spiegano il perché del diritto della crisi di impresa e dell’insolvenza."
"L’approccio del legislatore della crisi di impresa è fortemente mutato dal 1942, soprattutto alla luce di una diversa considerazione sociale dell’insolvenza, la quale, almeno fino agli anni 2000, costituiva uno stigma sociale e civile in cui l'obiettivo principale era quello di garantire la sollecita eliminazione dal mercato dell’impresa insolvente e alla liquidazione del suo patrimonio per il soddisfacimento dei creditori, soprassedendo sull’interesse alla conservazione degli organi produttiva. Tuttavia, a partire dal 2005, si è aperta una stagione di riforme rivolta a ridurre il numero delle procedure fallimentari e di bilanciare gli interessi coinvolti attraverso 1) la salvaguardia degli organismi produttivi ancora vitali; 2) il ridimensionamento del ruolo gestorio del giudice delegato e del tribunale a vantaggio degli altri organi della procedura; 3) il potenziamento degli strumenti negoziali di composizione della crisi. Simili interventi sono stati attuati sul corpo originario della legge fallimentare, provocando, nel tempo, una stratificazione che infine ha richiesto una riscrittura completa e coordinata del testo normativo. Tale necessità ha dunque condotta alla legge delega 155/2017 e all’istituzione del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, il quale si è rivelato non solo una risistematizzazione razionale degli interventi precedentemente stratificati, ma altresì l’occasione di introdurre nuovi istituti, tra i quali quelli diretti a fare emergere tempestivamente la crisi di impresa."
"Una panoramica degli attuali strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e procedure concorsuali.
La nozione di procedura concorsuale non è data dalla legge, ma, in seguito ad un accurato lavoro interpretativo di giurisprudenza e dottrina, si può concludere che le procedure concorsuali hanno per oggetto l'intero patrimonio dell'imprenditore e sono finalizzate a tutelare il diritto dei creditori di vedersi restituito ciò che gli spetta, per questo motivo sono informate al principio della par condicio creditorum stabilito dall’art. 2741 cc., in forza del quale i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.
Per altro verso, le procedure di regolazione della crisi non rispettano pedissequamente il principio della par condicio creditorum poiché i creditori sono liberi di disporre dei loro diritti e possono accettare trattamenti differenziati."
"La composizione negoziata della crisi è stata introdotto dal d.l. 118/2021 e recepita dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. Essa rappresenta un percorso facilitato- ed eventualmente protetto- attraverso il quale l’imprenditore può raggiungere l’obiettivo di risanare la propria impresa in difficoltà facendo ricorso agli strumenti dell’autonomia privata. Più nello specifico, la composizione negoziata non è diretta a regolare e comporre coattivamente i rapporti tra il debitore e i suoi creditori, ma consiste in un procedimento negoziale volontario in cui le trattative sono agevolate da un esperto, soggetto terzo e imparziale, mentre l’imprenditore mantiene la piena gestione dell’impresa."
"Si parla di conclusione delle trattative quando queste, quale che sia il risultato, giungono al termine, venendo a distinguersi dall’archiviazione che è il caso in cui l’esperto ritiene che le informazioni fornite dall’imprenditore siano prive di coerenza ovvero che non vi siano concrete prospettive di risanamento.
La legge descrive in modo articolato gli esiti possibili delle trattative e le traiettorie che le parti o il solo imprenditore possono percorrere."
" L’entrata in vigore del Codice della crisi segna il debutto del procedimento unitario, nell’ambito del quale il legislatore ha inteso convogliare tutte le istanze di regolazione concorsuale della crisi e dell’insolvenza.
In tale sede unica o unitaria confluiranno quindi tutte le domande o istanze, anche se tra loro contrapposte (si pensi ad un’iniziativa promossa del debitore oppure a quella di un creditore) che proseguiranno poi secondo la procedura più appropriata alla soluzione della difficoltà dell’impresa, secondo la valutazione operata dell’organo giurisdizionale competente.
Da punto di vista strettamente processuale, il procedimento non è realmente unitario, atteso che, dopo l’introduzione della domanda nel cosiddetto “contenitore unitario”, il primo grado di giudizio è caratterizzato dalla diversificazione dei percorsi processuali, a seconda che si intenda accedere alla regolazione pattizia o a quella liquidatoria. "
" La liquidazione giudiziale è la procedura che sostituisce il fallimento ed è finalizzata a liquidare il patrimonio dell’imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti. "
"Il presupposto oggettivo richiesto per l’applicabilità della procedura della liquidazione giudiziale, esso si sostanzia nello stato di insolvenza inteso come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni."
" La domanda di accesso alla procedura di liquidazione giudiziale deve essere presentata avanti al Tribunale, laddove i soggetti legittimati sono il debitore, gli organi e le autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa; uno o più creditori; oppure il pubblico ministero. Il pubblico ministero, in particolare, è tenuto a presentare la domanda per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha avuto notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza dell’impresa. Per altro verso, l’autorità giudiziaria ha comunque l’obbligo di segnalare al pubblico ministero lo stato di insolvenza dell’impresa ogniqualvolta venga accertata la condizione dello stato di insolvenza nel corso di un procedimento."
" Dalla data della sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale si producono una serie di effetti in capo al debitore e ai creditori.
Per quanto riguarda il debitore, l'effetto principale si sostanzia nello spossessamento che è funzionale sia alla cristallizzazione dell’attivo, sia alla gestione del patrimonio da parte del curatore, nell’interesse dei creditori. Si tratta di un effetto automatico che decorre dalla pubblicazione della sentenza.
Per quanto riguarda i creditori, l'effetto principale si sostanzia nella cristallizzazione del passivo, ossia dei debiti che gravano sul patrimonio del debitore per fatto anteriore all’apertura della procedura."
"Le disposizioni contenute nella Parte Prima – Titolo V – Capo I - Sezione IV del Codice hanno ad oggetto gli effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli per i creditori. Esse sono finalizzate a dare attuazione al principio generale della par condicium creditorum.
Per altro verso, per quanto riguarda i contratti pendenti, ossia quelli che risultano ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti nel momento in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale, la regola generale prevede la sospensione dell’esecuzione del contratto.
Una volta chiarite le sorti dei rapporti di cui sopra, e dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale, il curatore procede alla custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale."
"L’accertamento del passivo e dei diritti dei terzi è una fase essenziale della procedura concorsuale finalizzata all’individuazione dei crediti che devono essere soddisfatti con i beni compresi nella liquidazione giudiziale.
La liquidazione dell’attivo rappresenta la fase che ha la funzione di convertire in denaro i beni del fallito, ai fini del soddisfacimento dei creditori."
"La ripartizione dell'attivo può sinteticamente definirsi come l'operazione diretta ad individuare quantitativamente e qualitativamente la parte del ricavato dell'attivo che viene assegnato ai creditori concorrenti e il numero e la misura in cui costoro vengono soddisfatti."
"Il concordato nella liquidazione giudiziale è un istituto volto ad evitare la procedura di liquidazione giudiziale, che si realizza attraverso un accordo tra il proponente e i creditori, con l'intervento del Tribunale che provvede all'omologazione. Una volta approvato dalla maggioranza dei creditori ed omologato dall'autorità giudiziaria, il concordato è vincolante per tutte le parti. Il concordato nella liquidazione giudiziale va tenuto distinto dal concordato preventivo - che è una procedura concorsuale autonoma- poiché esso rappresenta uno strumento per consentire la chiusura anticipata della liquidazione."
"L’apertura della liquidazione giudiziale è tendenzialmente neutra rispetto all’organizzazione societaria, nel senso che, fermo restando lo spossessamento e la naturale conseguente compressione dei poteri degli amministratori, gli organi sociali restano in carica.
In questo contesto, il Codice delinea le cosiddette azioni di responsabilità che il curatore può iniziare o proseguire, ossia l'azione legale che consente di far valere in giudizio le inadempienze dei doveri imposti, per legge o per statuto, ai soggetti con compiti di amministrazione o di controllo all'interno di società di capitali o di società cooperative."
"L’estensione della liquidazione giudiziale non è legata ad una qualsiasi situazione di responsabilità illimitata del socio, ma alla responsabilità illimitata che caratterizza i tipi societari indicati dalla norma, vale a dire della società in nome collettivo, la società in accomandita semplice e la società in accomandita per azioni."
"L’articolo 259 del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza afferma che anche gli enti e gli imprenditori collettivi non societari e ai loro componenti illimitatamente e personalmente responsabili per le obbligazioni dell’ente sono assoggettati alla procedura concorsuale prevista per la società.
L'esercizio dell'attività imprenditoriale in forma collettiva vede lo svolgimento di un'attività d’impresa da parte di più persone, i soci, che decidono di apportare i mezzi necessari allo svolgimento del business oggetto della società. Nel caso in cui l’esercizio dell’attività imprenditoriale in forma collettiva preveda lo scopo di lucro come scopo secondario, si avrà un’impresa collettiva non societaria."
"La gestione stragiudiziale dell’insolvenza è un insieme di tecniche con cui si cerca di raggiungere accordi con i creditori, allo scopo di consentire una «onorevole» uscita di scena dell’imprenditore o, in alternativa, una ripresa dell’azienda, previa elaborazione di un opportuno piano industriale. L’accordo può consentire all’imprenditore di rimuovere situazioni di difficoltà e di preservare la continuità aziendale con interventi tempestivi, da attuarsi prima che lo stato di crisi diventi irreversibile. L’accordo stragiudiziale può portare ad un risultato più elevato per tutti gli stakeholders sia in termini di efficienza, riguardo il tempo e i costi, sia in termini di flessibilità in quanto svincolato dalle rigidità processuali."
"Il concordato preventivo è una procedura concorsuale attraverso la quale l’imprenditore ricerca un accordo con i suoi creditori per non incorrere nella liquidazione giudiziale e cercare di superare la crisi in cui versa l’impresa. L’obiettivo è quello di intervenire tra l’imprenditore e i propri creditori per pagare i propri debiti attraverso la presentazione di un piano. L’obiettivo del concordato preventivo consiste nel venire incontro sia alle esigenze nel titolare l’imprenditore che si trova in una situazione difficile sia a quelle dei creditori. Quindi, dal punto di vista del debitore, attraverso tale strumento può evitare tutte le azioni esecutive e conservare inalterata la sua attività, nonostante determinati limiti. Dal punto di vista del creditore, invece, è possibile evitare attese prolungate legate alla procedura della liquidazione giudiziale, ottenendo un parziale soddisfacimento di quanto gli è dovuto."
Gli organi della procedura sono: il Tribunale; il Giudice delegato; il Commissario Giudiziale; ed il liquidatore.
La domanda di concordato preventivo deve essere depositata con ricorso in Tribunale, nella sezione dedicata, in relazione al luogo in cui l’imprenditore ha il centro degli interessi principali."
"Nel concordato preventivo è presente un profilo negoziale rappresentato dalla volontà dei creditori i quali approvano o respingono, a maggioranza, la proposta del debitore."
"La procedura di concordato preventivo si chiude con la sentenza di omologazione (art. 113); tuttavia i suoi organi restano in carica per controllare l’esecuzione del concordato.
In particolare, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione - riferendo al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. Inoltre, ogni sei mesi redige un rapporto riepilogativo e lo trasmette ai creditori. Conclusa l’esecuzione del concordato, il commissario giudiziale deposita un rapporto riepilogativo finale. Per altro verso, il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato anche se presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata."
"Il concordato semplificato è un possibile sbocco della composizione negoziata, quando le trattative non abbiano portato ad altre soluzioni. Questa nuova procedura è utilizzabile soltanto dall’imprenditore che abbia seguito il percorso della composizione negoziata, sempre che le trattative siano state avviate per aver ritenuto l’esperto ricorrere concrete prospettive di risanamento e che, all’esito delle stesse, non sia stata individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendevano probabile la crisi o l'insolvenza."
"Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (“PRO”) è un nuovo strumento di regolazione della crisi introdotto all’art. 64-bis del Codice della crisi e dell’insolvenza (“CCI”) per mezzo del d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
Come gli altri strumenti di regolazione della crisi rientra tra quelle misure, accordi e procedure previste dall’ordinamento volte al risanamento dell’impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio, o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi."
"Una delle novità più interessanti introdotte dal nuovo Codice della Crisi e dell’insolvenza riguarda l’inserimento, nel sistema concorsuale, di una disciplina completa del gruppo di imprese.
Il Codice della Crisi e dell’Insolvenza precisa già all’articolo 2 che per gruppo di imprese si intende l’insieme delle società, delle imprese e degli enti che sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto."
"Dopo il 2012, la disciplina della crisi e dell’insolvenza delle imprese ha subito una transizione da un sistema dualistico puro, nel quale per le imprese era prevista una disciplina diversa da quella prevista per tutti gli altri soggetti, ad un sistema dualistico cosiddetto misto, intendendosi per tale quello nel quale continua ad esistere, in una situazione di crisi o di insolvenza, una differente disciplina per l’imprenditore e per il debitore cosiddetto comune, ma al secondo si applicano le regole di un sistema complementare che condivide, sia pure in forma semplificata, i principi di fondo dettati per gli imprenditori: ossia la possibilità di un concorso di tutti i creditori su tutti i beni del debitore,ma assicurando anche quest’ultimo, come già all’imprenditore, la possibilità a determinate condizioni, di beneficiare dell’esdebitazione."
"La liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale, alternativa alla liquidazione giudiziale. Trova applicazione a particolari categorie di imprese individuate dalla legge. Tra di esse si annoverano le imprese di assicurazione, le banche, le società cooperative, le agenzie territoriali per la casa (ex istituti case popolari), i consorzi obbligatori, le società fiduciarie e di revisione, etc. La differenza principale tra liquidazione coatta e la liquidazione giudiziale attiene alla partecipazione dell’autorità giudiziaria: difatti, nel caso della liquidazione giudiziale, la procedura si svolge integralmente nell’ambito giurisdizionale, assolvendo l’autorità giudiziaria anche ai compiti di natura amministrativa."
"L’esigenza di una disciplina speciale per le grandi imprese nasce dal fatto che la pluralità degli interessi che sono coinvolti dalla crisi d’impresa assume una più forte colorazione nel caso delle imprese di maggiori dimensioni, privilegiando la continuazione dell’attività di impresa per salvaguardare quegli interessi che sarebbero compromessi dalla cessazione dell’attività e dalla dissoluzione degli organismi produttivi. L’ amministrazione straordinaria è una procedura concorsuale che ha come principale finalità la conservazione, in tutto o in parte, di un’azienda (impianti e attrezzature) – destinata allo svolgimento dell’attività di un’impresa commerciale, o di un gruppo d’imprese, di grandi dimensioni dichiarata insolvente – nonché, a certe condizioni, del personale dalla stessa occupato. Anche questo procedimento, come la liquidazione coatta, ha natura amministrativa, poiché la sua gestione è affidata al Ministero delle attività produttive.
"Per quanto riguarda gli effetti dell’apertura dell’amministrazione straordinaria, essi riguardano i debitori, i creditori, gli atti pregiudizievoli e i rapporti pendenti."
"Nei primi anni duemila si è verificata in Italia la crisi di imprese di rilevantissime dimensioni, sollevando in seno al governo la necessità di contemplare una procedura che non sottoponesse le imprese ai tempi previsti dall’amministrazione straordinaria. Per tale ragione, a cominciare dalla crisi del gruppo Parmalat, furono previste misure che avrebbero dato vita ad una procedura che rappresenta una variante rispetto all’amministrazione straordinaria “comune” disciplinata dal d. lgs. 270/1999.
Di conseguenza, la disciplina della ristrutturazione industriale risulta dall’innesto di specifiche disposizioni nella disciplina dell’amministrazione straordinaria; per tale ragione, in questa sede verranno trattati solo i profili differenziati che caratterizzano la ristrutturazione aziendale."
La lezione sarà incentrata sullo studio delle fonti del diritto privato distinguendo tra fonti di cognizione e fonti di produzione.
Le singole fonti verranno poi analizzate in base al principio gerarchico spiegando quando l'una prevale rispetto all'altra. Al riguardo si terrà conto anche della impossibile contrarietà di una data fonte rispetto a quella ad essa gerarchicamente sovraordinata e, in particolare, analizzando il controllo di legittimità costituzionale pevisto dall'ordinamento.
In ultimo, a completamento della lezione, si accennano i limiti posti dai vincoli derivanti da obblighi internazionali e comunitari.
In questa lezione si affronta il tema dei soggetti di diritto partendo dalle definizioni di capacità giuridice e capacità di agire, spiegando i relativi modi di acquisto e le tipologie di atti che presuppongono requisiti e condizioni determinate dalla legge. La lezione prosegue poi sul'analisi della disciplina prevista in materia di capacità di agire del minore, illustrando quali sono le autorizzazioni necessarie al compimento di negozi giuridici, tenendo conto delle modifiche apportate dalla Riforma Cartabia sul processo civile.
La lezione è incentrata sul tema, iniziato in quella precedente, dei soggetti di diritto. In particolare si analizzeranno le disposizioni previsti dal codice civile per quanto concerne la capacità di agire del minore emancipato, interdetto, inabilitato e beneficiario dell'amministrazion di sostegno. Si illustreranno le procedure e le autorizzazioni richieste dalla legge al fine di compiere atti giuridici da parte di tali soggetti, tenendo conto delle modifiche apportate dalla Riforma Cartabia in materia.
In questa lezione si analizzerà la capacità delle persone giuridiche, in particolare quella degli enti distinguendoli in base ai criteri previsti dalla legge: presenza della struttura associativa, tipo di scopo perseguito, tipo di autonomia patrimoniale.
La lezione verà sulla spiegazione della distinzione tra fatto ed atto giuridico. Proseguendo si illustreranno le classificazioni dei vari negozi giuridici, distinguendo tra fattispecie semplici e complesse, fattispecie collegate, negozi inter vivos e mortis causa, negozi a titolo gratuito e a titolo oneroso, unilaterale e bilaerali e/o plurilaterali. In conclusione si analizzerà il negozio giuridico dal punto di vista sia spaziale che temporale, con un collegamento all'istituto della prescrizione e della decadenza.
La lezione verte sulla materia dei beni e dei diritti reali. In particolare si analizza la definizione fornita dal legislatore circa la qualificazione dei beni che possono formare oggetto di diritto. Proseguendo si illustreranno le classificazioni giuridiche dei beni fornite dal codice civile, in paricolare distinguendo tra beni immateriali e materiali, generici o specifici, fungibili e infungibili, divisibili e indivisibili, produttivi e non produttivi. Oltre alla classificazioni si avrà modo di analizzare le universalità di beni sia mobili che immobili, concludendo – sui beni che possono formare oggetto di diritto– con la definizione di pertinenza.
Proseguendo lo studio sarà incentrato sui diritti che nel dettaglio possono essere vantati sui beni, partendo dal diritto di proprietà, per poi seguire con l'analisi del modi di acquisto a titolo originario di questo stesso diritto.
La lezione prosegue nella trattazione iniziata con quella precedente concernente i beni e i diritti reali. In particolare si conclude l'argomento dei modi di acquisto della proprietà a titolo originario spiegando l'istituto dell'usucapione.
Per concludere lo studio circa il diritto di proprietà si esamineranno le azioni a difesa di tal diritto distinguendo tra a) azione revocatoria, b) azione negatoria, c) azione di regolamento dei confini e d) azioni per l'apposizione dei termini. Di queste si studieranno i requisiti, i termini di prescrizione e i relativi effetti seguendo le norme previste dal codice civile.
Proseguendo la lezione verterà sullo studio del diritto di possesso distinguendolo dalla detenzione e spiegando la particolare ipotesi di interversione. Anche per tal diritto si procederà successivamente allo studio delle azioni a sua difesa distinguendo tra a) azioni di reintegrazione, b) azione di manutenzione e c) azione di nunciazione.
A conclusione dello studio circa i diritti che possono vantarsi sui beni giuridicamente intesi, si analizzeranno quelli reali di godimento.
La lezione è incentrata sul diritto di famiglia. In particolare si spiegheranno i requisiti stabiliti dalla legge in virtù dei quali venga a configurarsi un nucleo familaire suscettibile di validi rapporti giuridici. Proseguendo si analizzerà il matrimonio, spiegando la differenza tra quello regolato dal diritto civile e quello invece regolato dal diritto canonico; si analizzerà altresì la struttura dell'atto, illustrando le tesi sulla natura giuridica di questo stesso. Proseguendo si spiegherà l'istituto della filiazione, quali sono i diritti dei figli, quali gli obblighi.
La lezione è incentrata sulla disamina del rapporto coniugale. In particolare si spiegheranno gli istituti della seprazione e dell'accordo di separazione, e lo scioglimento del matrimonio la cui causa è il divorzio. Nel dettaglio si illustrano quali sono i requisiti e le condizioni richieste dalla legge per poter addivenire all'uno o all'altro modo di estinzione del rapporto coniugale e, in particolare, quali sono gli effetti che ne derivano –sia per quanto riguarda i diritti personali che i diritti ti tipo patrimoniale.
In questa lezione si analizzerà il regime patrimoniale della famiglia, illustrando quale è quello previsto dalla legge, in mancanza di convenzioni matrimoniali, e come questa si sia evoluta nel tempo passando dalla seprazione dei beni alla comunione legale. Nel dettaglio poi si prosegue con l'analisi del fondo patrimoniale e della comunione dei beni per quanto concerne gli effetti sui diritti che competano ai titolari del rapporto coniugale, nonchè quelli spettanti ai propri discendenti.
In questa lezione si affronterà il tema di una particolare tipologia contrattuale a titolo gratuito quale quella delle donazioni. Anzitutto si spigheranno i criteri distintivi in base ai quali essa può essere individuata, in particolare partendo dalla definizione giuridica di liberalità e gratuità; gratuità che non sempre determina la qualificazione di un negozio come donazione, pertanto, si avrà modo di illustrare in quali casi nonostante la ricorrenza di tale requisito si è in presenza di contratti del tutto differenzi e non assimilabili a delle liberalità. Proseguendo la lezione si incentrerà sulla disciplina dettata dal codice, partendo dalla capacità di donare e di ricevere per donazione; quale può essere l'oggetto della donazione, distinguendo dal caso in cui essa consista in un dare o nell'assunzione di un obbligo; quale la forma richiesta per l'atto. In conclusione si analizzeranno particolari tipi di donazione regolati in modo differenziato dal codice civile, quale quella abnuziale, modale, il negozio misto con donazione e la donazione indiretta.
In questa lezione si inizierà lo studio delle obbligazioni. In particolare si analizzeranno i requisiti del rapporto giuridico dal quale possa desumersi la nascita di un obbligazione, ciò spiegando l'importanza della relizzazione dell'interesse altrui e la necessaria bilateralità del rapporto stesso– quali elementi essenziali della fattispecie in esame. Proseguendo si analizzeranno, in particolare, i tipi di interesse che le diverse tipologie di obbligazioni previste dall'ordinamento mirano a comporre e cosa possa formare oggetto di obbligazione– inteso come il comportamento che l'obbligato è tenuto ad avere. L'oggetto della prestazione e, quindi, dell'obbligo verrà poi analizzato in base alle classificazioni emerse: nel dettaglio si spiegherà in cosa consiste l'obbligo di un fare, o di un non fare, l'obbligo di un dare e la necessaria patrimonialità della prestazione, comune a tutti i tipi di obbligazioni assunte.
In questa lezione si analizzano le vicende che interessano il rapporto obbligatorio. Anzitutto si illustreranno ed esamineranno i modi di estinzione dell'obbligazione, partendo dall'adempimento. Al riguardo si analizzeranno le disposizioni del codice civile che regolano il comportamento che il debitore è tenuto ad avere nell'adempiere alla prestazione oggetto dell'obbligo da lui assunto; nel dettaglio si spiegherà cosa si intende per diligenza e correttezza e, come questi criteri debbano essere valutati al fine di decretarne il rispetto da parte del debitore. Si analzizeranno altresì i requisiti dell'adempimento, quali l'esattezza e l'integralità, spiegando quando il creditore possa o non possa ritenere sufficiente un adempimento soltanto parziale. Al riguardo si avrà modo di spiegare l'istituto della datio in solutum che consente al debitore di eseguire una prestazione diversa da quella dovuta con il consenso espresso del creditore. In ultimo si analizzeranno le disposizioni del codice civile per quanto concerno il tempo e il luogo dell'adempimento.
In questa lezione si esamineranno i modi di estinzione del rapporto obbligatorio diversi dall'adempimento, distinguendo tra i modi satisfattori e i modi non satisfattori– a seconda che all'estinzione del rapporto si accompagni o non il contestuale soddisfacimento dell'interesse del creditore. Si avrà modo pertanto di spiegare l'istituto della compensazione e della confuzione, quali modi satisfattori di estinzione dell'obbligazione, e l'istituto della novazione, della remissione del debito e dell'impossibilità sopravvenuto, quali modi non satisfattori di estinzione dell'obbligazione. Gli istituti, nel dettaglio, verranno analizzati sulla base dei requisiti richiesti dalle norme dettate dal codice civile e delle teorie eleborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza in ordine alla loro natura giuridica, la quale, si riflette sulla strutturazione del tipo di negozio giuridico utilizzabile e, di conseguenza, sui suoi effetti.
In questa lezione si analizzeranno le possibili modificazioni del rapporto obbligatorio, distinguendo tra i tipi di modificazione oggettiva-soggettiva, e le modifificazioni che riguardano il lato attivo e passivo del rapporto obbligatorio. Nel dettaglio, per quanto concerne le modificazioni soggettive attinenti al lato attivo del rapporto si analizzerà il contratto di cessione del credito e, segnatamente, la natura giuridica dello stesso, i requisiti richiesti dalle norme del codice civile e le diverse tipologie di cessione a cui è possibile ricorrersi. In particolare, poi, si spiegheranno quali sono gli effetti per quanto riguarda sia il rapporto tra cedente e cessionario sia il rapporto tra debitore ceduto e terzo cessionario. A completamento della lezione si analizzerà l'istituto della surrogazione per pagamento, che è il secondo modo attraverso il quale è possibile realizzare una modificazione soggettiva del lato attivo di un rapporto obbligatorio.
In questa lezione si analizzeranno le modificazioni soggettive del lato passivo. Anzitutto si partirà dall'istituto della delegazione spiegando che con questo stesso l'ordinamento giuridico permette di estinguere con un unico adempimento due distinti rapporti obbligatori, quale quello intercorrente tra delegante e delegato e, quello esistente tra delegante e delegatario. A tal riguardo si distinguerà tra delegatio promittendi, quando il delegato assume soltanto l'obbligazione del delegante, e delegatio solvendi, cioè quando il delegato estingue direttamente l'obbligazione del delegante. Ancora, si terrà conto dei diversi tipi di delegazione distinguendo tra quella titolata e astratta, al coperto e allo scoperto, liberatoria e cumulativa. La lezione prosegue poi con l'analisi dell'espromissione e l'accollo seguendo gli stessi criteri adottati per la spiegazione dell'isituto della delegazione, pertanto, si illustreranno quali sono i requisiti richiesti dalle norme del codice civile, quali sono le teorie elaborate dalla dottrina e giurisprudenza in ordine alla loro struttura dal punto di vista negoziale e quali sono gli effetti che ne derivano in termini di rapporti tra le parti.
La lezione è incentrata sul fenomento dell'inadempimento. Nel dettaglio si analizzeranno i requisiti richiesti dalle norme del codice civile al fine di poter decretare il mancato adempimento da parte del debitore della prestazione da lui dovuta e l'imputabilità dello stesso inadempimento ad un suo comportamento. A tal riguardo di spiegherà l'importanza della valutazione circa la diligenza utilizzata dal debitore, spiegando in quali casi e per quali motivi il debitore, quandanche inadempiente, non è tenuto al risarcimento del danno o, comunque, il creditore non può più pretendere l'adempimento. Tutto quanto spiegato sarà poi cordinato con le norme dettate in tema di colpa e dolo: si spiegherà quando la valutazione della colpevolezza e dell'intenzionalità possa condurre all'imputabilità dell'inadempimento al debitore, quando invece non rileva in ogni caso tale valutazione. Proseguendo la lezione continua sull'analisi del tipo di risarcimento dovuto al creditore distinguendo tra il danno causato da un illecito aquiliano (o extracontrattuale) e il danno come conseguenza diretta dell'inadempimento. La lezione si conclude con la spiegazione degli istituti a cui le parti di un rapporto obbligatorio possono ricorrere, al fine di evitare le conseguenze dell'inadempimento, quali la clausola penale e la caparra confirmatoria.
La lezione si incentra sull'analisi dei requisiti essenziali di un contratto, che sono fondamentali per la sua validità– quali la volontà delle parti, la causa, l'oggetto del contratto e la forma quando richiesta dalla legge a pena di nullità. Nel dettaglio si analizzano i tipi di accordi dai quali possa sorgere l'esistente di un contratto tra le parti che lo hanno raggiunto, spiegando in quali casi, e in quali invece non, rileva al tal fine la volontà –e quindi lo scopo– voluto dalle parti. Proseguendo si spiegherà in particoalre cosa si intende per causa del contratto, illustrando al riguardo le teorie elaborate dalla dottrina in ordine alla sua natura giuridica. Dalla causa del contratto si avrà modo di analizzare altresì la possibilità per i privati, ad espressione dell'autonomia negoziale, di concludere negozi cd. atipici e negozi cd. misti o collegati. A conclusione della lezione si spiegheranno quali sono i requisiti richiedi dalle norme del codice civile in ordine all'oggetto del contratto.
In questa lezione, continuando con gli argomenti spiegati nella precedente, si analizzerà l'ultimo requisito richiesto dalle norme del codice civile in ordine alla validità di un contratto e, segnatamente della forma– quando questa sia richiesta a pena di nullità. Si spiegherà qual è, in generale, la funzione a cui puo assurgere la forma di un negozio giuridico, quale quella di esteriorizzazione dell'atto umano, rendere possibile la pubblicità del negozio stesso, dirimere controversie. Al riguardo si terrà conto della distinzione tra la forma richiesta ad substantiam e quella richiesta ad probationem, spiegando gli effetti che derivano dall'uno e dall'altro tipo. Proseguendo si analizzeranno altresì gli elementi accidentali del contratto, quindi quelli che dalle norme del codice civile non risultano essere essenziali– in particolare per quanto concerne la condizione, il termine ed il modus.
La lezione è incentrata sullo studio delle ipotesi di invalidità del contratto quali la nullità e l'annullabilità. Anzitutto si partirà dalla definizione del concetto di nullità, illustrando quali sono le teorie elaborate dalla dottrina al riguardo– in particolare si distinguerà dall'ipotesi in cui il contratto nullo tolleri delle eccezioni per quanto riguarda la produzione di un qualche suo effetto e le ipoteci in cui, invece, non si ammette nessuna eccezione. Proseguendo si esporranno le diverse classificazioni della nulità eleborate da dottrina e giurisprudenza e si analizzeranno, poi, nello specifico le singole cause di nullità. In ultimo si analizzerà l'azione di nullità, nel dettaglio per quanto riguarda i soggetti che possono esperirla, se vi sono termini per il suo esercizio e se sia possibile sanare in qualche modo la nullità di un negozio giuridico.
Per quanto concerne l'annullabilità, allo stesso modo, si spiegherà anzitutto qual è il suo fondamento e la sua natura giuridica. Proseguendo si analizzeranno anche per tale vizio le singole ipotesi di annullabilità previste dalle norme del codice civile e, in conclusione, si illustreranno i modi attraverso i quali è possibile rimediare all'annullabilità di un contratto.
In questa lezione, per proseguire poi nella successiva, si analizzeranno le vicende che interessano il contratto. Nel dettaglio si spiegheranno gli istituti della risoluzione, della rescissione e della cessione. Partendo dalla rescissione si illustreranno i requisiti richiesti dalle norme del codice civile affinchè il contratto possa essere rescisso, distinguendo tra l'ipotesi di rescissione perchè si è contratti in stato di pericolo e, l'ipotesi, invece, in cui si è contratti in stato di bisogno. Proseguendo si esaminerà l'azione di rescissione in termini di soggetti che possano esercitarla, tempi richiesti, e possibilità di rimediare allo squilibrio contrattuale verificatosi. A seguire si analizzerà l'istituto della risoluzione del contratto, in particolare, per quanto concerne quella per inadempimento. Al riguardo si avrà modo di illustrare quali sono i rimedi esperibili dalle parti al fine di evitare l'esercizio dell'azione di risoluzione, la quale, richiede certamente tempi notamente lunghi. In particolare si inizierà a trattare, per poi proseguire nella successiva lezione, delle ipotesi di risoluzione di diritto.
La lezione continua sulla trattazione delle vicende del contratto, affrontata nella lezione precedente. Nel dettaglio si esaminano le altre due ipotesi di risoluzione di diritto quali il termine essenziale e la clausola risolutiva espressa. Al riguardo si avrà modo di illustrare quali sono i requisiti richiesti quali, invece, gli effetti dell'uno e dell'altro. Proseguendo la lezione sarà incentrata sugli altri due tipi di risoluzione e, cioè, quella per impossibilità sopravvenuta della prestazione ed eccessiva onerosità della stessa. In conclusione al tema trattato si analizzerà l'istituto della cessione del contratto, spiegando la sua natura giuridica –in base alle teorie elaborate in dottrina– e di conseguenza, la struttura richiesta per il negozio; quali sono gli effetti, in particolare, per quanto concerne i rapporti tra ceduto e cedente, ceduto e cessionario e tra cedente e cessionario.
In questa lezione si esaminerà l'istituto della rappresentanza. L'analisi verte anzitutto sulla distinzione tra rappresentanza diretta e indiretta, spiegando quali sono gli effetti prodotti nell'uno e nell'altro caso, quali sono i poteri riconosciuti al rappresentante e quali sono le fonti. Ulteeriore distinzione che sarà affrontata nel prosieguo della lezione è quella tra rappresentanza legale e volontaria. Per quella legale si rinvia alle lezioni precedenti sulle autorizzazioni necessarie, al fine di compiere negozi giuridici, nei casi in cui il rappresentato sia un incapace; pertanto, in particolare, l'esame verterà sul tipo di rappresentanza volontaria con espresso riferimento alla procura. Si analizzeranno i requisiti richiesti dal codice civile affinchè questa possa essere valida, quando non è possibile conferirla, quali tipologie si distinguono. In ultimo si esamineranno i vizi che possono inficiare il negozio di rappresentanza e l'ipotesi di conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato.
In questa lezione si esaminerà il contratto di compravendita. Uno dei contratti più ricorrenti nell'attività negoziale di diritto privato dei singoli. Anzitutto si partirà dall'analisi della sua natura giuridica, dei requisiti richiesti per esso dalle norme, e sulle caratteristiche del negozio che si riflettono sui relativi suoi effetti. Proseguendo si distinguerà tra i diversi tipi di vendita quali a) la vendita di cosa generica, b) la vendita alternativa, c) la vendita di cosa futura e d) la vendita di cosa altrui. Si analizzeranno poi, nel dettaglio, le obbligazioni gravanti in capo al venditore con riferimento alla particolare garanzia per evizione e garanzia per i vizi; in cocnlusione si esamineranno gli obblighi invece gravanti in capo al compratore.
In questa lezione si analizzeranno gli altri contratti di tipo traslativo, diversi dalla vendita, quali a) il riporto, b) la permuta e c)la somministrazione.
Per tutte e tre le tipologie contrattuali si esamineranno anzitutto i requisiti richiesti dalle norme del codice civile per quanto concerne, in particolare, la forma, i soggetti, l'oggetto e gli effetti. Ogni singolo contratto sarà spiegato dal punto di vista dei suoi elementi essenziali, così da fornire le competenze necessarie al fine di poter comprenderli e capire come essi vengano utilizzati nell'attività contrattuale dei privati.
In questa lezione si esamineranno i contratti di godimento e i contratti di prestito.
Per i contratti di godimento, in particolare, si studieranno a) la locazione e b) l'affitto.
Per i contratti di prestito, in particolare, si studieranno a) il comodato e b) il mutuo.
Per ogni tipologia contrattuale esaminata si spiegheranno i requisiti richiesti dal codice civile per quanto riguarda la loro struttura, la capcità dei soggetti, l'oggetto delle prestazioni. L'analisii sarà arricchita dagli orientamenti giurisprudenziali circa la loro natura giuridica e le possibili fattispecie atipiche che potrebbero configurarsi.
In questa lazione si tratteranno i contratti per la prestazione di servizi, in particolare del contratto di appalto e del contratto di mandato.
Le due tipologie contrattuali saranno esaminate in relazione alle norme previste dal codice civile per quanto riguarda i loro requisiti, i soggetti che possono stipularli, l'oggetto della prestazione e i relativi effetti.
In particolare per quanto riguarda l'appalto si esamineranno gli obblighi e i diritti in capo all'appaltatore e il committente; cosa comportano le modifiche apportare al progetto inizialmente pattuito, distinguendo tra quelle necessarie, non necessarie volute dall'appaltatore e non necessarie volute dal committente. L'analisi conclude con i tipi di responsabilità previsti in capo all'uno e l'altra parte del rapporto,
In particolare per il mandato, essendo esso convenuto finalizzato al compimento di attività giuridica per conto di un soggetto, si studieranno gli atti che possono essere compiuti dal mandatario e quali sono gli effetti che si producono nella sfera giuridica del mandante.
In questa lezione si esamineranno i contratti aleatori e i contratti di garanzia.
Partendo dai contratti aleatori si spiegheranno anzitutto i requisiti in base ai quali un contratto può definirsi tale. In particolare analizzando il concetto di alea la cui definizione non è stata fornita dal legislatore; si esporranno pertanto le teorie elaborate dalla dottrina sul tema. Proseguendo, si distinguerà tra i contratti che sono aleatori per legge e quelli che invece sono tali per volontà delle parti. Al riguardo si concluderà con lo studio del contratto di assicurazione.
Passando all'esame dei contratti di garanzia si esaminerà a) la fideiussione e b) l'anticresi. Entrambi saranno esaminati in base ai criteri stabiliti dal codice civile per quanto concerne i requisiti, i soggetti, l'oggetto e i relativi effetti. L'esame è arricchito dall'esposizione delle posizioni dottrinali e giurisprudenziali.
In questa lezione si esamineranno i contratti nelle liti. In particolare a) la transazione, b)la cessione dei beni ai creditori, c) il compromesso e d) il sequestro convenzionale. La lezione sarà inizialmente incentrata sulla disamina dei caratteri generali del contratto stipulabile al fine di risolvere una controversia. L'esame verterà sulla causa del contratto che è determinante ai fini della configurazione di siffatto tipo contrattuale se la risoluzione della controversia è elemento essenziale del contratto. Al riguardo si esporranno le teorie dottrinali e giurisprudenziali prevalenti elaborate sul tema. Le suddette tipologie contrattuali, nel dettaglio, verranno esaminate in base alle norme previste dal codice civile– talvolta anche del codice di procedura civile– per quanto concerne i requisiti, i soggetti, l'oggetto e i relativi effettivi. I contratti nelle liti non costituendo una categoria unitaria e circoscritta, richiederanno altresì l'esposizione, durante il corso della lezione, degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in ordine alle singole caratteristiche previste per essi.
In questa lezione si esamineranno i contratti che hanno un contenuto socialmente tipico, i quali, hanno avuto origine e diffusione negli ordinamenti giuridici di stampo anglosassone. In particolare si esamineranno tre figure contrattuali particolarmente diffue nell'ambito dell'attività negoziale dei privati (anche del pubblico).
In particolare si studieranno a) il contratto di leasing, b) il contratto di factoring, c) di brokeraggio e d) di sponsorizzazione. Essendo contratti atipici si ricostruiranno le prevalenti tesi dottrinali e giurisprudenziali in ordine ai loro requisiti, carattere essenziali e capacità dei soggetti stipulanti. L'analisi è arricchita dall'individuazione degli schemi contrattuali tipici che ad essi sono assimilabili, fornendo le competenze necessarie al fine di individuarne la disciplina applicabile
L'integrazione europea è il processo di integrazione industriale, politico, legale, economico (e in alcuni casi anche sociale e culturale) di tutti o alcuni ...
I trattati dell'Unione europea sono l'insieme di trattati internazionali, stipulati tra gli Stati membri, che pongono le basi dell'ordinamento giuridico ...
Le fonti del diritto e i principi generali
Il principio di sussidiarietà e il principio di proporzionalità
Le fonti del diritto dell'Unione Europea
L'interpretazione delle norme e i principi generali del diritto
Il diritto derivato vincolante: i regolamenti e le direttive
Il diritto derivato non vincolante: le raccomandazioni e i pareri
Differenza tra diretta applicazione ed effetti diretti
Le direttive e gli effetti diretti
Principi alla base delle competenze del diritto dell'Unione Europea
La struttura istituzionale dell'Unione Europea: il Consiglio europeo
La struttura istituzionale dell'Unione Europea: il Consiglio
La struttura istituzionale dell'Unione Europea: il Coreper
La struttura istituzionale dell'Unione Europea: la Commissione europea
La struttura istituzionale dell'Unione Europeo: l'Alto rappresentante per gli affari esteri
La struttura istituzionale dell'Unione Europea: il Parlamento Europeo
La struttura istituzionale dell'Unione Europea: la Corte di giustizia
La struttura giurisdizionale dell'Unione Europea
Il ricorso per annullamento e i vizi degli atti comunitari
Il ricorso in carenza: caratteristiche, requisiti ed effetti
Il rinvio pregiudiziale: finalità e particolarità
Il rinvio pregiudiziale e pronuncia della Corte di giustizia
La funzione consultiva della Corte di giustizia
L'adattamento al diritto dell'Unione Europea
Percorsi normativi e legislativi: la legge comunitaria
La legge europea e la legge di delegazione europea
La Corte Costituzionale, la legge comunitaria e l'approccio dualista
La politica estera e di sicurezza comune (PESC) e l'azione estera dell'Unione Europea
La politica estera e di sicurezza comune: caratteristiche specifiche
L'azione esterna dell'Unione Europea
Introduzione. evoluzione storica del “diritto penale tributario” (avv. mario garavoglia); il diritto penale tributario: “sottosistema” o “microsistema”? (prof. avv. alex ingrassia)
gli illeciti omissivi: quali prospettive nel periodo della crisi? (avv. alfredo foti); agevolazioni fiscali nel periodo della crisi e per la crisi: gli scenari del contenzioso (dott. marco di siena)
le confische: da “arcipelago” a “penisola”? (avv. prof. andrea de lia); illeciti tributari e misure di prevenzione (avv. prof. tommaso rafaraci)
il concetto di “frode” nel sistema penale-tributario (prof. andrea perini); fiscalità internazionale: una overview su operazioni infragruppo, transfer pricing e residenza all’estero (avv. alessandra mereu e avv. benedetto santacroce)
la responsabilità dell’ente: la colpa in organizzazione, le prospettive sugli adempimenti, il problema del bis in idem (avv. francesco colaianni); il diritto penal-tributario ed il processo. profili di tecnica difensiva (avv. serena silvestri)
la responsabilità del professionista nella consulenza e nell’ assistenza fiscale (avv. gianluca gambogi); la deontologia del difensore nel processo per reati penal-tributari (avv. bernardo cartoni)
L'hardware si riferisce a tutti i componenti fisici e tangibili di un computer o di un sistema informatico. È tutto ciò che puoi toccare e vedere. Include il computer stesso (la scatola), la tastiera, il mouse, il monitor, la stampante, e tutti i componenti interni come il processore, la memoria RAM, l'hard disk, la scheda madre e la scheda video. Senza hardware, non esisterebbe il computer!
Il software è l'insieme delle istruzioni, dei programmi e dei dati che dicono all'hardware cosa fare. A differenza dell'hardware, il software è intangibile: non lo puoi toccare, ma è ciò che rende il computer "intelligente" e funzionale. Si divide principalmente in software di sistema (come il sistema operativo) e software applicativo (come i programmi per scrivere, navigare su internet o giocare).
Un sistema operativo (SO) è il software più importante di un computer. È come il "cervello" che gestisce tutte le operazioni di base, permettendo all'hardware e al software di comunicare tra loro. Senza un sistema operativo, un computer non potrebbe funzionare. Gestisce la memoria, i processi, i file e le periferiche (stampanti, mouse, ecc.). Esempi comuni sono Windows, macOS e Linux.
Approfondiamo il cuore del sistema operativo, focalizzandoci su come interagisce con te e gestisce il computer!
Vediamo più nel dettaglio come questo "cervello" ti permette di utilizzare il computer in modo efficace e quali sono le sue responsabilità quotidiane.
La seconda parte sui sistemi operativi si concentra sulle loro funzioni principali e sull'interazione con l'utente. Il SO fornisce un'interfaccia grafica (quello che vedi sullo schermo, con icone e finestre) che ti permette di usare il computer in modo intuitivo. Gestisce anche l'installazione e la disinstallazione dei programmi, la sicurezza, gli aggiornamenti e l'organizzazione dei file e delle cartelle sul disco.
Una rete di computer è un insieme di due o più dispositivi interconnessi (come computer, stampanti, smartphone) che possono comunicare tra loro e condividere risorse (file, stampanti, connessione internet). Lo scopo principale di una rete è facilitare lo scambio di informazioni e la collaborazione tra utenti. Esistono diversi tipi di reti, come le LAN (Local Area Network) che collegano dispositivi in un'area limitata (es. casa, ufficio) e le WAN (Wide Area Network) che coprono aree geografiche più ampie.
Questa sezione approfondisce i componenti e i concetti base delle reti. Si parlerà di server (computer che offrono servizi ad altri dispositivi della rete), client (dispositivi che usufruiscono dei servizi del server), router (dispositivi che indirizzano il traffico di dati tra diverse reti) e switch (dispositivi che collegano i dispositivi all'interno di una singola rete). Verranno spiegati anche i concetti di indirizzo IP e i protocolli di comunicazione che permettono ai dispositivi di "parlarsi".
Internet è la più grande rete di computer al mondo, una "rete di reti" globale che collega miliardi di dispositivi e milioni di reti più piccole. Permette lo scambio di informazioni, la comunicazione e l'accesso a una quantità illimitata di risorse. I suoi servizi più noti includono il World Wide Web (le pagine web che navighiamo), la posta elettronica, i servizi di messaggistica e lo streaming.
La seconda parte su Internet si concentra sui servizi e gli strumenti per navigare. Verranno spiegati i browser web (programmi come Chrome, Firefox, Edge) usati per visualizzare le pagine web, il concetto di URL (l'indirizzo di una pagina web), i motori di ricerca (come Google) per trovare informazioni, e la differenza tra sito web e pagina web. Si parlerà anche della sicurezza base online e dell'importanza di navigare in modo consapevole.
La posta elettronica (email) è un servizio che permette di inviare e ricevere messaggi digitali su una rete, principalmente Internet. È uno degli strumenti di comunicazione più diffusi nel mondo professionale e personale. Per usare la posta elettronica, hai bisogno di un indirizzo email (es. nomecognome@esempio.it) e di un client di posta (un programma o un servizio web) per gestire i tuoi messaggi.
Questa parte approfondisce l'uso pratico della posta elettronica. Si tratterà di come scrivere e inviare un'email, allegare file, gestire la casella di posta (cartelle, spam), rispondere e inoltrare messaggi. Verranno anche spiegate le regole di buona condotta (netiquette) per le comunicazioni via email e i concetti di sicurezza legati al phishing e alle email malevole.
Gli applicativi (o "applicazioni" o "app") sono programmi software specifici progettati per svolgere compiti particolari per l'utente. A differenza del sistema operativo, che gestisce il computer, gli applicativi sono ciò che usiamo per lavorare, divertirci o comunicare. Esempi comuni includono i programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, browser web, programmi di grafica, lettori multimediali e videogiochi.
La seconda parte sugli applicativi si concentra sull'installazione, gestione e aggiornamento. Verrà spiegato come scaricare e installare un'applicazione, come disinstallarla, l'importanza degli aggiornamenti per la sicurezza e le nuove funzionalità. Si parlerà anche delle diverse categorie di applicativi (desktop, web, mobile) e dei software a pagamento versus software gratuiti (freeware, open source).
Microsoft PowerPoint è un software per la creazione di presentazioni. Permette di combinare testo, immagini, grafici, video e audio in slide (diapositive) per comunicare idee in modo visivo e coinvolgente. È ampiamente utilizzato in ambito lavorativo, accademico e personale per esporre progetti, lezioni o resoconti.
Questa sezione coprirà le funzionalità base di PowerPoint. Si imparerà a creare una nuova presentazione, inserire testo e immagini, utilizzare layout predefiniti, applicare temi e sfondi, e gestire l'ordine delle slide. Verranno introdotte anche le modalità di visualizzazione e le opzioni di salvataggio del file.
Microsoft Outlook è un client di posta elettronica e un gestore di informazioni personali integrato. Non è solo per le email, ma offre anche funzionalità di calendario, gestione contatti, attività e note. È molto usato in ambienti professionali per organizzare la comunicazione e il lavoro.
Present simple, present continuous, past simple, past continuous, present perfect, future, will, be going to, may, might, will, have to, be allowed to, must/mustn’t.
Present simple, present continuous, past simple, past continuous, present perfect, future, will, be going to, may, might, will, have to, be allowed to, must/mustn’t.
Present simple, present continuous, past simple, past continuous, present perfect, future, will, be going to, may, might, will, have to, be allowed to, must/mustn’t.
Connettivi tra frasi, aggettivi, pronomi, avverbi, preposizioni, relative clauses (where, which, who, which, whose, that). Passive form: present simple, past simple, interrogative form. Should, ought to, have better to, should/shouldn’t have to.
Connettivi tra frasi, aggettivi, pronomi, avverbi, preposizioni, relative clauses (where, which, who, which, whose, that). Passive form: present simple, past simple, interrogative form. Should, ought to, have better to, should/shouldn’t have to.
Connettivi tra frasi, aggettivi, pronomi, avverbi, preposizioni, relative clauses (where, which, who, which, whose, that). Passive form: present simple, past simple, interrogative form. Should, ought to, have better to, should/shouldn’t have to.
Present perfect continuous, used to, get/be used to, first conditional, second conditional, Wish + past simple, could, was/were able to, managed to, third conditional, wish + past perfect, mixed conditionals.
Present perfect continuous, used to, get/be used to, first conditional, second conditional, Wish + past simple, could, was/were able to, managed to, third conditional, wish + past perfect, mixed conditionals.
Present perfect continuous, used to, get/be used to, first conditional, second conditional, Wish + past simple, could, was/were able to, managed to, third conditional, wish + past perfect, mixed conditionals.
Past perfect. Before, after, when, by the time, because, already, never. Passive: present perfect passive, present continuous passive, past perfect passive, past continuous passive, will passive, be going to passive. Use of the -ing form. Phrasal verbs (get, make, do).
Past perfect. Before, after, when, by the time, because, already, never. Passive: present perfect passive, present continuous passive, past perfect passive, past continuous passive, will passive, be going to passive. Use of the -ing form. Phrasal verbs (get, make, do).
Past perfect. Before, after, when, by the time, because, already, never. Passive: present perfect passive, present continuous passive, past perfect passive, past continuous passive, will passive, be going to passive. Use of the -ing form. Phrasal verbs (get, make, do).
Parole di uso quotidiano (famiglia, emozioni, oggetti, contesti giuridici ed economici, cibo, vestiti, ambiente, parti del corpo)
Parole di uso quotidiano (famiglia, emozioni, oggetti, contesti giuridici ed economici, cibo, vestiti, ambiente, parti del corpo)
Brevissimi cenni sul sistema giuridico e amministrativo britannico.
Saverio Setti è Dirigente presso il I Reparto Reclutamento, Affari Giuridici ed Economici del Personale dello Stato Maggiore, oltre ad essere consulente esterno per la Procura Generale militare presso la Suprema Corte di cassazione e professore a contratto di diritto militare presso l'Università Link Campus di ...
chi è Saverio Setti ?Laureata in Diritto dell'Innovazione per l'Impresa e le Istituzioni presso l'Università di Pisa discutendo una tesi dal titolo "L'arbitrato marittimo" con relatore il Prof. Avv. Claudio Cecchella. Ha, altresì, conseguito un Master in Giurista dell'Economia e Manager Pubblico presso ...
chi è Morena Capja ?Ho conseguito la Laurea in Economia delle imprese e dei Mercati - Amministrazione e Controllo delle Imprese (L28 dm 509/99) presso l'Università degli studi di Roma Tre con un elaborato in Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche: “L’evoluzione della nozione di impegno nei sistemi contabili ...
chi è Katia Carcone ?Assegnista di ricerca in diritto penale presso Scuola Superiore Sant’Anna ( ENGINE: Engaging Men and Boys against Gender-based Violence and Discrimination through Technology-based Trainings) Dottorato di ricerca in diritto penale Tesi di dottorato: Dealing with the Deals: Settlement Agreements for National and Inte...
chi è Roberta De Paolis ?Laureata in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Napoli Parthenope con votazione 110/110 con lode discutendo una tesi sulle partecipazioni rilevanti nelle società per azioni quotate. Svolge la pratica notarile e frequenta Corsi di aggiornamento in ambito notarile. ...
chi è Aurora Di Maio ?Mirko Forti è attualmente ricercatore in Diritto dell'Unione europea presso l'Università degli Studi della Tuscia. Ha conseguito la Laurea Magistrale con lode in Giurisprudenza presso l'Università di Pisa (2014) e il Dottorato di Ricerca in Diritto Internazionale ed Europeo presso l'Universit...
chi è Mirko Forti ?Il Comitato Scientifico di Formazione Cammino Diritto è composto da professori universitari, magistrati, notai, avvocati e dirigenti pubblici di consolidata preparazione ed esperienza, capaci di accompagnare gli iscritti ai Corsi online in un percorso innovativo ed unico nel panorama nazionale. Il coinvolgimento di num...
chi è Formazione Cammino Diritto ?Chi è il Dott. Raffaele Giaquinto: Un Ponte tra Diritto e Digitale Con una carriera che si snoda all'intersezione tra la robustezza del diritto e la dinamicità dell'informatica, il Dott. Raffaele Giaquinto è una figura poliedrica e innovativa. Attualmente Direttore e Responsabile dello Sviluppo So...
chi è Raffaele Giaquinto ?Linda Brancaleone è dottoressa magistrale in giurisprudenza presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell'Università "Magna Græcia" di Catanzaro, dove si è laureata con una tesi in diritti umani (settore disciplinare IUS/20). Collabora con le cattedre di Filosofi...
chi è Linda Brancaleone ?

Concorsi pubblici ed esami.